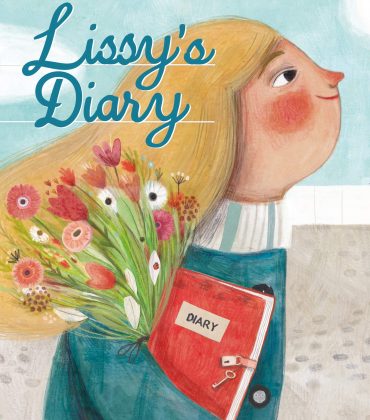Toponomastica femminile, l’associazione che testimonia la storia delle donne nei nomi delle vie delle nostre città, organizza in collaborazione con il Premio Italo Calvino di Torino un concorso di narrativa per le scuole. La sezione Narrazioni è riservata a studenti del triennio superiore o universitari. I racconti brevi in concorso devono rispettare tre indicazioni: restare entro le diecimila battute, vertere sul tema “Le vie della parità” e partire da uno dei quattro incipit ideati da alcuni scrittori e scrittrici.
Tra i premiati c’è il racconto di Gabriele Fuschino, studente di quarta del liceo Porporato di Pinerolo. L’ho letto e apprezzato, poi ho deciso di pubblicarlo sul blog perché in questo suo scritto Gabriele parla della sua nonna, donna siciliana forte e coraggiosa. L’incipit è di Antonio G. Bortoluzzi, in corsivo.
Nei miei occhi il tuo sguardo. La donna che mi insegnò il coraggio
Alla fine mi è toccato guardarmi allo specchio. E giuro che non lo volevo fare. Avrei preferito girare un po’ su Instagram, vedere che c’è di nuovo, o al limite scendere di casa e fare una corsa al parco: sudare mi ha sempre fatto bene, fin da bambino. Però lo specchio mi dice che se riuscissi a raccontare tutto, fino in fondo, sarei per una volta dalle parti della verità.
Ho sempre avuto due metà: una felice e sorridente, l’altra depressa e sola. Guardandomi riflesso allo specchio cerco ciò che mi manca, ciò che ho perso o forse non ho mai avuto. I miei occhi sono pieni di rabbia, le due mani chiuse a pugno in posizione di guardia: sono Vincent Cassel in “L’odio”.
Non so perché, guardandomi, mi torna alla mente quel sogno. “Gabbriè! Gabbriè! Vieni ad apparecchiare la tavola che tra poco viene tu macie”. La voce aveva un suono caldo, rassicurante. Andavo in cucina, la trovavo seduta al tavolo intenta a grattugiare il parmigiano, il suo volto era accarezzato dalla luce del sole. Mi sedevo accanto a lei, la guardavo. “Nonna, che ci fai qua?”. “Tu mi stavi cercando” rispondeva. Le usciva sangue da una nocca, si era tagliata con la grattugia come al solito. Mi prendeva le mani e diceva, con la voce di nonna: “Figghiu di Dio, hai tutte le mani ruvinate…”. “Quante vote ti dissi di mettere la crema, ah?! Quante?!” continuava con la voce rimproverante d’una madre. Io rimanevo in silenzio. “Mani così le avevo ai tempi dei turni in fabbrica e delle sere da Gianfaldoni, quando sparecchiavo i tavoli dell’alta società torinese, mentre tua bisnonna andava a pulire le loro case; dormivo tre ore a notte per sfamare tua madre e i tuoi zii”. Si fermava pensierosa. “Tuo nonno se ne andò di casa cinque volte ed io lo perdonai quattro, finché alla quinta non tornò chiù… Ma l’avrei perdonato di nuovo: lo amavo, ma soprattutto amavo i miei figghi, loro avevano bisogno di un padre”.
“Nonna, perché mi stai raccontando questo?”. “Gabbriè, i tuoi occhi, la risposta è nei tuoi occhi. Ora, figghiu mio, vai dalla vicina a chiedere un accendino, che devo appicciare il fornello per far bollire l’acqua, tra poco dobbiamo mangiare. Picchì mi guardi accussì? Non ti ricordi che ci hanno staccato la corrente? Vai, fai quello che ti dissi”. Mi alzavo pieno di dubbi, non capivo cosa volesse dire. La risposta era nei miei occhi? Che significava? Mi sorrideva, le sorridevo. Camminavo fino all’uscio, ma quando mi giravo per cercare conforto nel suo sguardo non la vedevo più.
Mi ero svegliato di soprassalto, tutto sudato, in lacrime. Ma ora forse inizio a capire il messaggio del sogno, perché nel mio riflesso ritrovo mia nonna. In me vedo ciò che lei era: dolce e divertente, alle volte scontrosa, triste a volte, mentre fissava il vuoto. La vita l’ha privata di un padre, della propria terra, di un matrimonio sereno, di una situazione economica stabile e della salute. Mia nonna non ha mai avuto pace, e io con lei. Nei miei occhi ci sono le tracce della mia esperienza: frammenti del passato, sprazzi di luce e ombre, persone vicine e lontane, cattive e buone, abbracci e schiaffi.
Allo scorrere di queste immagini, nelle mie orecchie risuonano dolci dialettismi siciliani e urla, e certe frasi sono tatuate nella mia anima. Vedo me stesso a 13 anni. Ho i capelli arruffati e ricci, indosso una tuta larga e delle scarpe bucate, un ragazzo mi chiama “pagliaccio” davanti alle ragazze più belle della scuola. Mi rivedo a 8 anni. Al parco, dei bambini si avvicinano a me chiedendo di giocare insieme: accetto e questi iniziano a cantare in coro “Ciccio-bomba cannoniere”.
Vedo l’addetto del gas che entra in casa per bloccare la valvola, non potevamo pagare, e guardando me e mia nonna intimoriti, se ne va scrivendo nel suo registro di non aver trovato nessuno. La vedo distesa sul letto osservarmi e dire: “Non piangere figghiu di Dio, nella miseria siamo nati e nella miseria dobbiamo vivere, è così”.
E la vedo ancora alla finestra, l’ultimo vero ricordo che ho di lei. Le serrande sono abbassate, ma nella camera buia penetrano dei raggi di luce, mio fratello dorme. “Nonna devo uscire, torno subito”, le dico, ma non risponde; “Nonna”, mi avvicino nel silenzio della camera. Si gira, le lacrime le rigano il viso. Si libera in un pianto tra le mie braccia e a denti stretti ripete: “Non mi vuole più nessuno”.
Sì, avrei preferito non guardarmi allo specchio, non ricordare. E allora indosso una tuta e le scarpe da ginnastica ed esco. Scendo le scale. Alle mie spalle il portone del palazzo si chiude nel solito frastuono, a ogni passo il cielo si fa più buio, la poca luce che rimane combatte con il tramonto. La città è un’immensa orchestra: un insieme di voci, motori di auto, freni che stridono, clacson assordanti, tazzine e bicchieri che sbattono nell’acquaio del bar vicino a casa. I miei passi danno il ritmo alla sinfonia, con l’intercalare del mio respiro. Giro in Via Stefano Cambiano, illuminata dalle luci dei negozi che si intervallano alle palazzine. Percorro il Viale della Rimembranza, i cavalli si affacciano dai cancelli dell’ippodromo. Passo davanti al mio liceo e, dopo Piazza Vittorio Veneto, imbocco i portici della mia città. Poi continuo a camminare fino alla caserma della forestale ormai costruita: me la ricordo quando era ancora un cantiere. Arrivato ai binari, non più in funzione, mi affaccio e controllo alla mia destra e alla mia sinistra: rimane pur sempre una via per i treni, almeno per me.
Scorgo il cartello di Via Puccini. Abitava il mio amico Angelo in quella via. Mia nonna mi ci veniva a prendere la sera, reduce da un pomeriggio passato a giocare in giardino; dopo c’era la merenda, per finire poi la giornata davanti ai videogiochi più spaventosi e violenti. Avevo 6 anni. Poco più avanti un altro cartello: Via Carducci. Un cane abbaia da dietro un cancello. Intravedo la casa di Antonio e Andrea, frequentavano le medie quando quest’ultimo mi aveva dato del figlio di puttana. Mio fratello Francesco gli diede uno schiaffo in pieno viso e scappò via. Ricordo che, dopo essermi venuto a prendere a scuola, si fermò davanti casa loro, e “Se esce gliene do un altro”, mi disse. La tenda si era scostata, ma nessuno si affacciò. Imparai il linguaggio della violenza, fatto di minacce e silenzi. Avevo 6 anni.
Sul finire della strada, una casa gialla e rossa. Mi fermo. Un ricordo anche qui. Io e Michela giochiamo a pallone. Uno dei due calcia la palla così forte che va a finire nel giardino dietro. “Nonna!” gridiamo. “Cu è che grida?!”. “Nonna! Ci accompagni da Maria a prendere il pallone, per favore? Per sbaglio è finito di là” le chiediamo. “Mace di Dio, ma non potete fare più piano con sti calci? Eh va bene! Però è l’ultima vota ah!”. Abbiamo di nuovo il pallone. “Grazie, signora Maria, la prossima volta faremo più attenzione”, all’unisono io e mia sorella. Promessa poi non mantenuta, “disgraziati” come eravamo. Così continuiamo a giocare, mentre mia nonna e Maria non smettono più di parlare.
Un rumore mi riporta al presente, è il motore di una macchina. Un fuoristrada parcheggia a pochi passi da me. Dalla portiera del conducente esce una donna sulla cinquantina. Faccio finta di aspettare qualcuno: passeggio avanti e indietro spazientito, con il telefono in mano. Suona il campanello. “Chi è?” “Nonna!” La porta della casa si apre, qualcuno l’accoglie in un caldo abbraccio. Sulla strada cala il silenzio, il mio cuore si riempie di nostalgia. Ritorno sui miei passi, salutando i ricordi del passato.
Quando la malattia ha preso il sopravvento su di te non potevo accettarlo. Rabbia e odio mi pervadevano il corpo. Gli zii venivano a trovarti e ti guardavano con pietà: avrei voluto cavare loro gli occhi. Non sapevano chi eri veramente. Quando tutti ti dicevano “Vattene via, quella famiglia è piena di problemi. Ad aiutarli non ti resterà più un soldo”, tu rispondevi “Mia figghia e i picciriddi non li lascio in mezzo a una strada”. Forse avresti fatto meglio ad andartene, pensai alcune volte. Non te ne sei andata: ancora una volta hai preferito la famiglia, la TUA famiglia, a una vita tranquilla. Sei una guerriera, io l’ho capito proprio quando, sola, hai toccato il fondo. Ancora adesso lotti, cercando di parlare, anche se ti costa tanta fatica, cercando di fare ciò che da sola non puoi più.
Non capiterà mai che io dimentichi la tua voce, il tuo sguardo. Lo stesso sguardo pieno della voglia di combattere che oggi il pugile avversario vede dentro i miei occhi. Voglio dirti “grazie”, grazie di non averci lasciati soli, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, per i tuoi figli e i tuoi nipoti. Ho in mente le tue lacrime quando te lo sussurrai, il mio grazie: avevi capito. Porterò in me ogni tuo insegnamento, orgoglioso della mia nonna divorziata, operaia, meridionale, che morirà nella malattia. Orgoglioso della donna che è stata ed è Silvia. Io sangue del tuo sangue. Come te, a testa alta, senza indietreggiare mai.
La foto di copertina è di Luciano Allione.
Questo racconto e la notizia del concorso di narrativa mi sono arrivati da Vita-mine Vaganti, rivista ufficiale dell’associazione Toponomastica Femminile, un bellissimo spazio virtuale che vi consiglio di seguire. Dalla presentazione del sito:
Vita-mine vaganti restituisce alla memoria le storie di donne cadute nell’oblio, si fa portavoce delle minoranze, distrugge e decostruisce gli stereotipi, rilegge la storia adottando punti di vista lontani rispetto a quelli canonicamente conosciuti e, per non farvi mancare nulla, suggerisce anche delle ottime e squisite ricette.
In questi post si parla di altre coraggiose donne siciliane: Franca Viola, Rosa Balistreri, Letizia Battaglia.